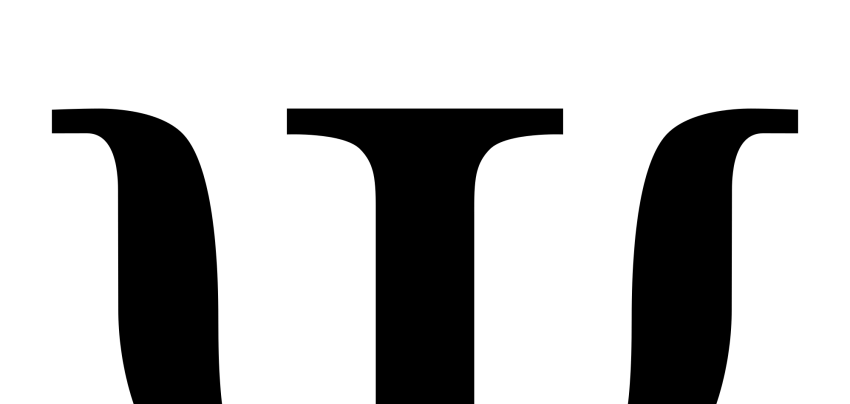La competitività del timido
Ho scelto un titolo provocatorio, con parole non corrette, ma che in qualche modo delineano i confini dei concetti di cui vorrei scrivere.
Pensiamo al “timido” come a chi con fatica si espone. Quello che ha un inglese scolastico, ma oh, era bravo a scuola… Insomma un’indicazione la saprebbe chiedere, una volta atterrato a Londra. Ma non lo fa. Non lo fa perché se immagina se stesso sbagliare pronuncia, arrancare alla ricerca del vocabolo giusto o commettere un errore grammaticale, si vergogna, e pure tanto. Si vergogna anche quando immagina se stesso non capire la risposta dell’interlocutore… “Farei finta di aver capito”, si dice, “ma forse l’altro capirebbe che sto facendo finta…”. Che vergogna!
Pensiamo al “timido” come a quello che durante una riunione, un corso, una lezione o forse anche solo in mezzo a un gruppo di conoscenti o amici parla poco, non fa domande, non dà risposte anche se le conosce, non racconta aneddoti. Se lo fa -qualche volta lo fa- è certo di aver parlato male, di essere arrossito, di aver avuto la voce tremula. E si vergogna tutte le volte che ci ripensa.
E pensiamo al “timido” come a chi si priva non solo di queste piccole (davvero così piccole?) esperienze, ma anche di vissuti più grandi. Evitamento su evitamento rischia di costringersi in una comfort zone insoddisfacente e che, probabilmente, è al di sotto delle sue capacità. Finisce per privarsi di esperienze di apprendimento (come faccio ad arrivare ad avere una buona pronuncia dell’inglese se, in inglese, non ci parlo?) e di trovarsi obiettivamente sguarnito di capacità e risorse.
Cosa c’entra allora la competitività? Proviamo a pensare a una ipotetica infanzia del nostro “timido” amico: forse tutte le volte che la sua figura di riferimento cercava di insegnargli qualcosa, lo faceva cercando appunto di in-segnare. Mettere dentro. Mettere dentro un insegnamento senza rispettare tempi, modi e sensibilità del bambino, rischia di risultare una forzatura, con scarsi risultati. E l’insegnante che vede scarsi risultati potrebbe diventare critico verso il suo allievo, potrebbe schernirlo o abbandonarlo a sé, privarlo di attenzione. Potrebbe confrontarlo con gli altri allievi più bravi, potrebbe etichettarlo negativamente. Non nasce in fondo con queste modalità l’ansia da prestazione?
Se la mia performance sarà buona, allora mamma/papà/la maestra mi tratteranno meglio. Diranno che sono bravo, lo racconteranno a tutti con orgoglio, mi confronteranno con gli altri “inferiori” e sorrideranno ammiccando verso di me. Mi sentirò apprezzato.
Nei casi più gravi, mi sentirò amato solo se sarò bravo. Il più bravo.
Il “timido” (mi si passi l’uso improprio del termine, di nuovo) spesso vuole solo essere il più bravo perché non ha imparato che, a non esserlo, va bene lo stesso. Si è di valore e amabili e degni di rispetto TANTO QUANTO prima. Non l’ha imparato. Così come non ha imparato a tollerare quella frustrazione dell’insuccesso, perché quando ne ha avuti da piccolino, di insuccessi, nessuno si è seduto accanto a lui con amore a verbalizzare quelle emozioni, quella frustrazione, a normalizzare senza banalizzare, ad abbracciarle, a osservare con rispetto. Ed eccola, la vergogna. Cos’è successo durante l’infanzia? Cos’è successo nella relazione coi propri genitori o con altri adulti di riferimento? Se sbaglio e mamma/papà/la maestra mi dicono quelle brutte cose, mi guardano in quel brutto modo o non mi considerano più, beh allora vuol dire che c’è qualcosa in me di sbagliato, gli altri lo vedranno.
Nasce qui la vergogna.
A volte, probabilmente più spesso, il “timido” prende la strada dell’evitamento descritta prima. Perché, facile: se non faccio non sbaglio, se non mi espongo nessuno noterà quanto io sia sbagliato. Se non partecipo alla competizione, non posso perderla.
Altre volte però il “timido” persegue con tenacia un’utopica perfezione e si espone, e vince, ed eccelle anche di frequente. E ne continua a volere come un drogato cerca la sua droga.
La -nascosta- timidezza del competitivo.
Due facce della stessa medaglia.